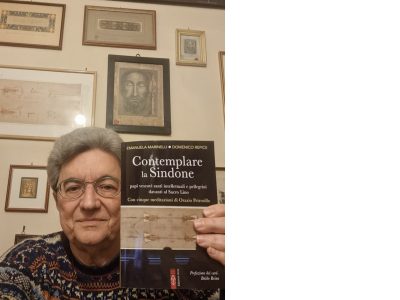Le interviste sono pubblicate integralmente come inviate dall’intervistato
 Laureata in ” Criminologia e Giustizia Penale”, perchè questa scelta?
Laureata in ” Criminologia e Giustizia Penale”, perchè questa scelta?
La scelta di intraprendere un Master in “Criminologia e Giustizia Penale” nasce durante il mio percorso di laurea triennale in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”. In particolare, deriva dall’esigenza personale di approfondire temi affronta duranti i miei studi, come il diritto internazionale, da un punto di vista diverso. Mi interessava comprendere non solo le dinamiche politiche e giuridiche, ma anche cosa si cela dietro il “comportamento criminale” e come la società risponde. Il Master mi ha permesso di unire questi aspetti e studiare la criminalità da diverse prospettive. In questo modo, ho potuto anche approcciarmi a diverse modalità di “trattamento”, che non si limita alla sola azione punitiva, ma anche e soprattutto rieducativa e riabilitativa.
Che cosa comprende la Criminologia, quali i criteri per definire ” criminale ” una persona?
La Criminologia può essere definita come una scienza multidisciplinare, poiché si fonda sulle basi di discipline differenti ma essenziali per analizzare la criminalità, chi la perpetra e chi la subisce, quali, ad esempio, la psicologia, la sociologia, la giurisprudenza, l’antropologia o la medicina psichiatrica. Di conseguenza, non può essere adottata un’unica definizione del “soggetto criminale”. Farlo porterebbe al rischio di cadere in assunzioni semplicistiche che non analizzano i fenomeni o le esperienze che ne influenzano il comportamento. Nel corso del tempo, il modo di osservare il “delitto” è cambiato e non si limita più all’associazione di quest’ultimo con condizioni puramente biologiche o fisiologiche dell’individuo. Nonostante l’importanza di fattori neuro-psicologici, è fondamentale definire il comportamento criminale da una prospettiva che prende in considerazione fenomeni di tipo, e non solo, sociale, economico, culturale o istituzionale. Inoltre. è necessario adottare un approccio che non si ferma all’osservazione del solo soggetto che perpetra un crimine ma considera anche le vittime e i contesti circostanti.
Oggi sono cambiati i crimini e la tipologia di chi li commette?
Il mondo è cambiato in maniera esponenziale nel corso del tempo e, allo stesso modo, anche le forme di criminalità, i cosiddetti profili criminali e gli strumenti utilizzati per commettere reati. Possiamo facilmente riagganciarsi al tema della tecnologia: negli ultimi anni, reati considerati più tradizionali come truffe e rapine hanno assunto un carattere diverso con anche il progresso del mondo digitale. Infatti, sono molto più frequenti le frodi informatiche, l’accesso e la diffusione non consensuale di materiale privato, o la diffusione di vere e proprie campagne di odio online. L’identità del “soggetto criminale” è variegata e non classificabile sotto un’unica categoria. Parlare di criminalità oggi richiede anche di affrontare tematiche come quelli della diversità e dell’inclusione. Si parla costantemente di questi temi, ma ci troviamo in una realtà in cui l’intolleranza verso ciò che è percepito come “diverso” è considerabilmente aumentata. In Italia si registrano casi crescenti di discriminazioni e aggressioni a sfondo razziale, sessista e omofobo, spesso alimentate sui social, dove l’anonimato, sopracitato, e la logica del “noi contro loro” amplificano la violenza verbale e normalizzano il linguaggio d’odio. Questo tipo di intolleranza digitale può poi tradursi anche in comportamenti reali, come aggressioni fisiche o vandalismi simbolici. La diversità e l’inclusione possono essere rilette anche nel contesto delle istituzioni, che affrontano questi temi come opposizioni ideologiche e non in maniera trasversale. In un ambiente in cui spesso si evita di creare coesione ma, contrariamente, si alimentano narrative e discorsi divisivi, la percezione di insicurezza cresce così come la possibilità di violenza. Si può dire quindi che la criminalità di oggi riflette l’intersezione di molteplici fattori che richiedono nuovi mezzi per la prevenzione e il contrasto.
Il criminale è una persona debole e quanto la famiglia ha influito sui suoi comportamenti…E i social?
Utilizzare la parola “debolezza” per descrivere o classificare il comportamento criminale sminuirebbe cosa può celarsi dietro di esso. Il contesto familiare è chiave nel riconoscimento e nell’analisi del comportamento di chi commette un crimine. Ad esempio, un ambiente nel quale la violenza, non necessariamente fisica, ma anche verbale e psicologica, sono centrali, può avere una notevole influenza su come viene percepita la realtà. A volte, ricorrere a metodi violenti o criminali sembra l’unica strada per sopravvivere ad un mondo esterno che non si conosce o che appare distante dal proprio. O ancora, un contesto nel quale le emozioni non vengono ascoltate ma represse o screditate, potrebbe compromettere la formazione dell’empatia e della moralità, e portare all’insorgenza di sentimenti di frustrazione e repressione che, di conseguenza, possono influire sulla relazione con gli altri e la percezione della realtà circostante. Esistono molteplici variabili legate al contesto familiare che influenzano il modo di affrontare la vita di chi li vive. Tale fattore deve essere analizzato profondamente nel momento in cui si tenta di comprendere cosa ha spinto una determinata persona a compiere un crimine o ricorrere alla violenza. I social oggi costituiscono parte integrante della nostra vita. Siamo circondati dalla costante condivisione di immagini e modelli che esaltano l’ostentazione, il successo, la ricchezza e la bellezza costruita. Bombardati da tali continui messaggi, è facile cadere in una trappola fatta di competizione, senso di inferiorità rispetto al prossimo e frustrazione. Questo non significa che i social creino dei criminali ma possono avere un forte impatto sulla costruzione dell’identità di un individuo. La voglia di sentirsi “visti” e la facilità nella condivisione di contenuti potrebbero portare all’adozione di comportamenti e gesti estremi, poi condivisi online. Tramite i social, in cui l’anonimato può essere un mezzo, la diffusione di odio e violenza è diventata estremamente semplice: non avere un contatto diretto e nascondersi dietro profili non riconoscibili diminuisce la percezione del peso e delle conseguenze reali di ciò che si dice o fa, quasi annullandole.
“Delitto italiano”, “Delitto Europeo” che differenza?
Potremmo definire “Delitto Italiano” un reato previsto e punito dal Codice Penale Italiano, poiché contrario alle leggi e ai principi che regolano l’ordinamento giuridico nazionale. i tratta, quindi, di comportamenti che minano la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità dello Stato. Non esiste, invece, una definizione giuridica univoca di “delitto europeo”. Tuttavia, questa espressione può essere intesa come un insieme di reati che contrastano o minacciano gli interessi comuni dei Paesi membri dell’Unione Europea — come, ad esempio, la tutela delle frontiere, la lotta al terrorismo, al riciclaggio, alla corruzione o ai crimini ambientali. In questo senso, il “delitto europeo” rappresenterebbe una categoria concettuale più ampia, fondata sulla cooperazione giudiziaria e sulla difesa dei valori condivisi tra gli Stati membri.
E le leggi italiane ed europee sono diverse in valutazioni e in pene e in che delitti?
Sì, le leggi italiane ed europee possono differire sia nella definizione dei reati, nelle valutazioni giuridiche e nelle pene previste. Questo avviene perché, pur condividendo principi comuni (come la tutela dei diritti umani e la parità di genere), ogni Stato mantiene autonomia legislativa in materia penale.Come esempio potremmo prendere i crimini di odio, spinti da motivi e sentimenti discriminatori. In Italia, tali reati non vengono trattati come autonomi ma la discriminazione è trattata maggiormente come un’aggravante. In altri Paesi dell’Unione Europea tali crimini sono invece reati a sé e affrontati con pene dedicate e programmi volti al proprio trattamento.
Più donne o più uomini e in che età vengono commessi maggiormente reati criminali?
Al fine di fornire una risposta accurata a questa domanda, sarebbe necessario paragonare dei dati ben strutturati che mettono a confronto le tipologie di reato rispetto al genere dell’individuo che lo commette. In linea di massima, potremmo dire che sono più alte le statistiche di uomini che delinquono. In particolare, possiamo osservare un aumento nell’incidenza dei reati commessi da ragazzi giovani, che spesso formano delle vere e proprie “gang” criminali. La criminalità femminile rappresenta un fenomeno meno diffuso. Tuttavia, è importante sottolineare che la criminalità femminile riceve ancora poca attenzione, sia a livello mediatico sia nelle analisi sociali. Spesso viene letta attraverso stereotipi — come l’“eccezione” o l’“anomalia” — invece di essere studiata come fenomeno complesso, con dinamiche proprie. Comprendere anche questa dimensione è fondamentale per una lettura più completa e realistica della criminalità, perché solo analizzando le differenze di genere in modo equilibrato si possono costruire politiche di prevenzione e rieducazione davvero efficaci. Inoltre, questo permetterebbe di comprendere anche con più esattezza qual è il rapporto tra genere e criminalità, e quali sono i contesti, fenomeni e fattori che influenzano la scelta di ricorrere a tale comportamento.
E i giovani? L’emulazione è un fattore importante ( considerando la giovane età…) Si potrebbe dare meno divulgazione mediatica del delitto e meno ” protagonismo” del “protagonista “… Potrebbe aiutare? cosi come lezioni di difesa personale nelle scuole e nei centri sociali…?
Sì, assolutamente. Ridurre la spettacolarizzazione mediatica dei delitti e del loro autore potrebbe essere un passo importante per limitare fenomeni di emulazione, soprattutto tra i più giovani, che sono più vulnerabili all’influenza dei modelli negativi proposti dai media. Dare meno spazio al “protagonismo” del colpevole e più attenzione alla vittima, al contesto e alla prevenzione aiuterebbe a cambiare la narrazione e a responsabilizzare il pubblico. Partire dall’educazione è fondamentale e credo sia uno dei primi passi per aumentare la consapevolezza e avviare il cambiamento: partire fin da piccoli con percorsi di educazione al rispetto e al consenso, insegnando che i “no” vanno ascoltati, che le relazioni devono essere paritarie e che il rispetto dei limiti altrui è un valore fondamentale. L’educazione al consenso, insieme a una comunicazione responsabile e a un’educazione affettiva più strutturata, può davvero essere il primo passo per costruire una cultura diversa, più sana e rispettosa.
Per una ” giustizia penale “GIUSTA, quanto sono importanti le valutazioni sociali e famigliari e quali?
Per una giustizia penale realmente giusta, le valutazioni sociali e familiari sono fondamentali, poiché il reato non deve essere concepito come un atto isolato, ma come un fenomeno che nasce in un contesto umano, sociale e relazionale. Ignorare tale contesto porta con se il rischio di adottare una giustizia meccanica e non efficace, con il solo obiettivo di punire. Contrariamente, bisogna comprendere cosa si cela dietro il comportamento criminale per poterlo prevenire e trattare in modo adeguato. Tra le valutazioni più rilevanti possiamo distinguere: Fattori socio-economici: condizioni in cui si vive, livelli di povertà, marginalizzazione ed esclusione sociale. Contesto familiare: presenza di famiglie disfunzionali, assenza di figure di riferimento, pressione o aspettative. Fattori Psicologici: traumi, abusi, mancanza di maturità emotiva, presenza di disturbi psichiatrici. È importante sottolineare che i fattori che influenzano il comportamento umano possono essere molteplici e spesso interconnessi. Un’analisi attenta, che tenga conto di questi diversi aspetti, consente di elaborare percorsi personalizzati e realmente efficaci. Ciò permetterebbe di rafforzare le misure rieducative e preventive, superando una visione puramente punitiva della giustizia.
Un criminale “non è un uomo o una donna”…?
Il “soggetto criminale” non può essere definito semplicemente come uomo o donna, poiché il crimine o la violenza non sono intrinsecamente “maschile” o “femminile”. Diversamente, il comportamento viene influenzato da una serie di fattori sociali, culturali, psicologici, economici, e non dal sesso biologico. Ridurre chi commette un’attività illecita a “donna” o “uomo è una semplificazione altamente pericolosa che non prende in considerazione il contesto circostante. Serve a sottolineare che la criminalità riguarda persone, non categorie di genere, e che ogni valutazione di responsabilità deve partire dall’individuo e non da stereotipi.